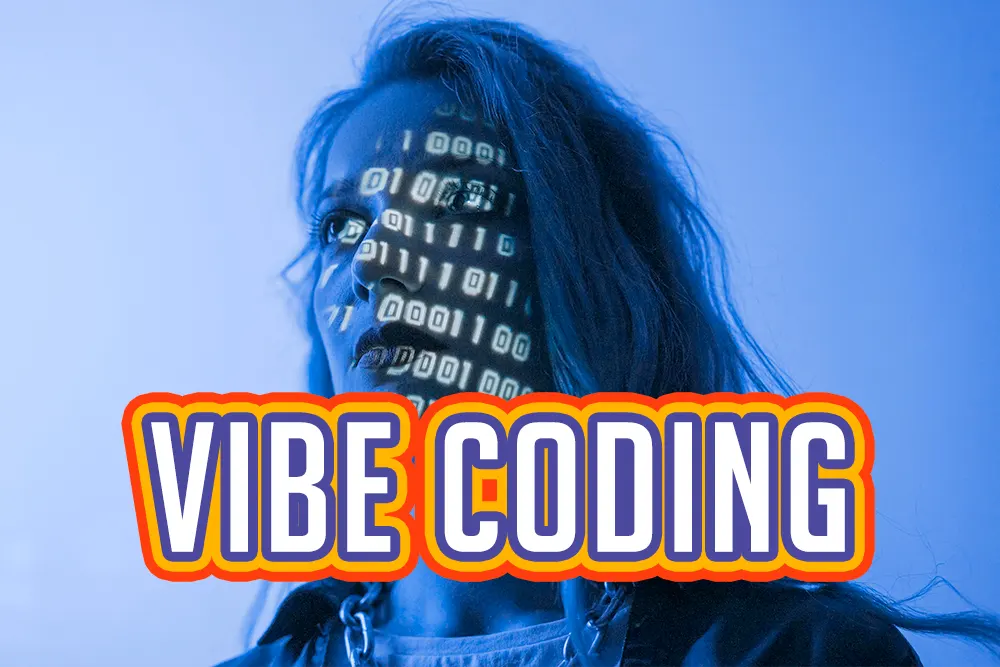x
Che cosa indica il termine scelto dal Collins Dictionary come parola dell’anno e quali parole aiutano a capire come oggi si interagisce con l’intelligenza artificiale
(Clicca sui termini sottolineati per leggere la definizione sul dizionario Slengo)
Per il Collins Dictionary, “vibe coding” è la Word of the Year 2025. L’espressione si è presa la scena battendo termini che negli ultimi mesi avevano fatto parecchio rumore, tra cui clanker, insulto diretto ai robot e alle IA diventato virale su TikTok, e poi biohacking, glaze, aura farming, Henry, taskmasking, coolcation, micro-retirement e broligarchy. Tutti indicatori di un anno dominato da tecnologia, auto-miglioramento e performance sociale. Ma è “vibe coding” ad aver colto lo spirito del tempo con più precisione.
Cos’è il vibe coding
Il termine è stato coniato nel febbraio 2025 da Andrej Karpathy, pioniere dell’intelligenza artificiale e figura di riferimento nel settore. L’idea è semplice: invece di scrivere manualmente il codice, si descrive in linguaggio naturale ciò che si vuole ottenere, e l’AI genera l’applicazione o il sito al posto nostro. In altre parole, non si parte più da variabili, cicli e librerie, ma da un prompt. Chi ha poca esperienza può chiedere: “Creami un programma che gestisce i miei pasti settimanali”, e vedere comparire un’app funzionante.
Secondo il Collins, il termine rappresenta bene un cambiamento profondo: la programmazione sta diventando più accessibile e la barriera tecnica si abbassa grazie a strumenti capaci di tradurre l’intenzione umana in codice. Naturalmente resta una zona d’ombra: il codice generato non è garantito, può contenere bug o scelte discutibili, ed è qui che entra in gioco l’esperienza umana.
Come si parla all’AI: i termini oggi in uso
Quando si parla di vibe coding emergono quasi sempre tre anglicismi che, negli ultimi mesi, si sono stabilizzati anche nell’italiano comune dei programmatori: prompting, prompt whispering e prompt engineering. Sono tutti termini nati in inglese, ma usati anche da noi perché descrivono con precisione il tipo di interazione che abbiamo con l’AI.
Il prompting è la base: dare un’istruzione in linguaggio naturale e aspettarsi che l’AI la traduca in qualcosa di utile. È l’azione che rende possibile il vibe coding nella sua forma più immediata.
Poi c’è il prompt whispering, un’espressione più informale, circolata soprattutto online, che indica il saper trovare la formulazione “giusta”: quella frase calibrata, detta quasi “a bassa voce”, che fa ottenere all’AI esattamente ciò che vogliamo.
Infine c’è il prompt engineering, il termine più tecnico dei tre, usato quando la costruzione del prompt diventa un vero lavoro di progettazione: strutturare il testo, inserire vincoli, dare esempi, impostare formati. Qui non si improvvisa; è una competenza che molti stanno sviluppando proprio perché il vibe coding funziona solo se le istruzioni sono pensate bene.
Accanto a questi anglicismi, nella discussione italiana compare spesso anche low-code/no-code, un’etichetta già consolidata che indica piattaforme in cui la programmazione richiede poco o nessun codice esplicito. Non è un sinonimo di vibe coding, ma si incrocia con esso nel modo in cui abbassa la soglia tecnica e avvicina alla programmazione persone che fino a poco tempo fa ne erano lontane.
Quando il vibe coding diventa un rischio: i termini da conoscere
L’idea di descrivere un’app e vedere l’AI generare il codice è affascinante, ma non elimina i problemi classici della programmazione. Anzi, aumenterà sempre di più la necessità di mettere una pezza a inesattezze e ridondanze. È il motivo per cui, quando si parla di vibe coding, ricompaiono termini già noti nel gergo degli sviluppatori e perfettamente calzanti per descrivere ciò che può andare storto.
Il cargo cult programming è il caso in cui si accetta il codice senza capirlo davvero, un po’ come imitare rituali senza conoscere il senso originale. Con il vibe coding il rischio è simile: prendere per buono ciò che l’AI produce, anche quando non è chiaro come funzioni.
Il cowboy coding rimanda invece allo sviluppo senza regole, dove si procede a istinto, senza pianificazione né controlli: un approccio che può emergere quando si genera codice velocemente e lo si integra senza un vero progetto.
Lo shotgun debugging nasce quando, per risolvere un problema, si prova un po’ di tutto finché qualcosa sembra funzionare; un comportamento che capita facilmente anche quando si ritocca un prompt più volte, sperando che una delle varianti “aggiusti” il bug.
E poi c’è lo spaghetti code, il codice aggrovigliato e difficile da manutenere, che può emergere se si accumulano pezzi generati dall’AI senza un disegno coerente.
Infine il duct tape programming, la soluzione tampone messa lì per far andare avanti il progetto anche se non è elegante né robusta.
Questi termini, già presenti da anni nel vocabolario tecnico, oggi ritrovano spazio perché descrivono benissimo le situazioni in cui si può inciampare quando il codice non lo scrivi tu, ma un modello che interpreta, bene o male, ciò che gli hai chiesto.
Perché il vibe coding ha vinto
La scelta del Collins fotografa una tendenza chiara: la programmazione sta diventando una conversazione. Non è più questione solo di conoscere i linguaggi, ma di saper comunicare con l’intelligenza artificiale. E questa trasformazione è culturale prima che tecnica. Il vibe coding è immediato, potenzialmente rivoluzionario, e descrive una fase in cui l’AI non è più uno strumento specialistico ma un mediatore tra idee e prodotti digitali.
In un anno segnato da entusiasmo, critiche e dibattiti sull’uso dell’intelligenza artificiale, “vibe coding” è la parola che riesce a mettere tutto questo in una cornice chiara: la tecnologia cambia la programmazione e, di conseguenza, la lingua che l’accompagna.
Secondo Dictionary.com, invece, la parola dell’anno 2025 sarebbe “six seven”. Se ti interessa l’argomento, leggi il nostro articolo qui sotto.