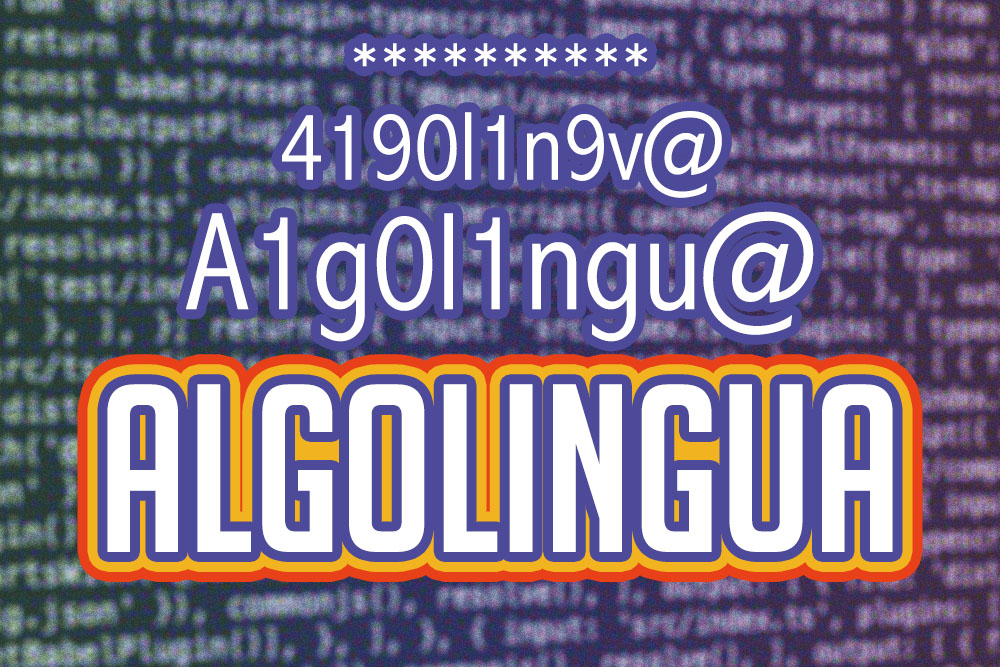x
Parole vietate, codici creativi e slang digitale: l’algolingua è il modo in cui la rete reinventa la comunicazione per sfuggire agli algoritmi
Nell’era dei social media, il linguaggio non si evolve più soltanto per imitazione, prestito o mutamento spontaneo. Sempre più spesso, le parole nascono, cambiano o si impongono per una ragione precisa: piacere all’algoritmo. O, perlomeno, non dispiacergli. Questo fenomeno ha un nome: algolingua. Ed è qualcosa che riguarda da vicino anche l’italiano.
Algolingua: definizione e contesto
Per “algolingua” (anche nota come con il termine inglese “algospeak”) si intende l’insieme di strategie linguistiche che gli utenti mettono in atto per adattarsi alle regole, spesso implicite, imposte dagli algoritmi delle piattaforme digitali. Non si tratta solo di evitare la censura, ma anche di ottimizzare la diffusione dei propri contenuti, aumentarne la visibilità, entrare in comunità specifiche o semplicemente aggirare barriere tecniche.
Gli algoritmi, infatti, non capiscono davvero il linguaggio: lo processano. E quel che non riconoscono, lo penalizzano. Ciò ha portato alla nascita di un modo di parlare e scrivere pensato per essere efficace prima per la macchina, poi per gli esseri umani.
Dal SEO all’algoritmo: una continuità
Chi lavora sul web sa bene cos’è la SEO (Search Engine Optimization): inserire parole chiave in un testo per favorirne il posizionamento nei motori di ricerca. Con l’arrivo dei social, la logica si è estesa: ora le parole chiave servono anche per essere trovati e spinti dai feed algoritmici.
Un contenuto che include un termine riconosciuto, magari virale, ha più possibilità di essere mostrato a chi ha già interagito con altri contenuti simili. Da qui la nascita di etichette, micro-etichette e hashtag, usati non solo per classificare, ma per esistere nel sistema. Il successo della parola “cottagecore” su TikTok, e il proliferare dei suffissi -core, ne è un esempio evidente. Ma anche l’italiano, nel suo piccolo, comincia a seguire la stessa dinamica.
L’italiano sotto algoritmo
Sebbene i social siano spesso dominati da contenuti anglofoni, anche la lingua italiana si sta adattando. Lo vediamo nei gerghi giovanili, ma anche nel lessico dei creator, che si affida sempre più a formule riconoscibili per i feed.
Termini come “cringe”, “triggerare”, “delulu”, “sigma”, “skibidi”, usati in contesti italiani, spesso non sono semplici prestiti, ma strumenti di posizionamento. Se un video include un termine che l’algoritmo sa essere di tendenza, quel contenuto ha più probabilità di circolare. Di conseguenza, entrare nel vocabolario di una community digitale è anche un modo per farsi spazio sulla piattaforma.
Una forma ricorrente di algolingua in italiano riguarda la censura visiva di parole sensibili, per evitare che vengano intercettate dai filtri automatici delle piattaforme. È frequente, ad esempio, vedere parole come su1cid1o, dr0ga o pist*la, parole sensibili scritte in forme alterate, con asterischi, barre, spazi o simboli grafici al posto di alcune lettere, oppure sostituite da sinonimi vaghi o eufemismi. Un esempio celebre di eufemismo algoritmico viene dall’inglese, dove il verbo “unalive” viene usato per riferirsi al suicidio senza incorrere in ban.
Queste modifiche aiutano a evitare la demonetizzazione, la riduzione della visibilità o perfino la rimozione dei contenuti. Sebbene le forme specifiche cambino da utente a utente, la tendenza è chiara: alterare le parole per eludere la moderazione automatica, mantenendo comunque intelligibile il significato per chi legge.
Un altro caso emblematico è l’uso dell’emoji del cocomero (🍉) per riferirsi alla Palestina, diffuso soprattutto su TikTok e Instagram. Questa sostituzione ha un valore sia simbolico, perché richiama i colori della bandiera palestinese, sia strategico, perché consente di parlare di temi geopolitici evitando penalizzazioni algoritmiche. È un esempio chiaro di linguaggio cifrato usato per rendere comunicabili concetti altrimenti a rischio di censura.
Un’applicazione specifica di queste strategie è il Voldemortaggio (o Voldemorting): l’uso di eufemismi e censure per evitare di pronunciare il nome di personaggi celebri e potenti, che si considerano problematici, in modo da non dare loro ulteriore visibilità, spingendoli nelle grazie dell’algoritmo, e/o non attrarre l’attenzione loro e dei loro sostenitori. Negli Stati Uniti abbondano i nomi in codice per riferirsi a Donald Trump (“Tacos”, “Cheeto” o “45”), mentre in Italia registriamo la nostra buona dose di nomignoli per i politici, come “il Papeete” come sostituzione del nome di Matteo Salvini.
La pressione a etichettarsi
Una delle conseguenze più sorprendenti dell’algolingua è la creazione e diffusione di etichette identitarie. In passato, uno poteva definirsi goth, emo, punk. Oggi, nel contesto online, le micro-etichette riferite a stili estetici si moltiplicano: “goblincore”, “weirdcore”, “dark academia”, “clean girl”.
Queste parole servono a segnalare all’algoritmo chi sei e cosa ti piace. Sono metadati travestiti da identità. E il fenomeno si riflette anche in Italia: chi si identifica nel personaggio della gattara pazza, chi posta contenuti “cozy”, chi si riconosce in estetiche derivate direttamente da Tumblr o TikTok, spesso calate in un contesto locale.
Tutto questo è alimentato dalla logica del feed personalizzato: più sei etichettabile, più contenuti ti verranno proposti, e più sarai spinto a produrre contenuti in linea con quell’etichetta. L’identità linguistica si fa branding.
La lingua come codice
Un altro aspetto dell’algolingua riguarda la creazione di un linguaggio in codice per sfuggire alla censura o riconoscersi come membri di un gruppo chiuso. In contesti repressivi, questo assume una dimensione politica (come in Cina o a Hong Kong), ma anche nei social italiani si intravedono codici:
- parole distorte o scritte con numeri per aggirare i filtri;
- doppi sensi e metafore condivise solo da chi è dentro la cultura online;
- uso creativo di emoji o simboli.
Questi codici rinforzano il senso di comunità e, insieme, creano nuovi modi di esprimersi, che a volte sopravvivono ai filtri e diventano parte integrante del linguaggio.
Un linguaggio condizionato ma non spento
Chi osserva questi fenomeni con nostalgia o allarme parla spesso di “decadenza” della lingua. In realtà, la creatività linguistica è più viva che mai. L’algolingua non è una degenerazione, ma un adattamento. I vincoli imposti dagli algoritmi funzionano come quelli imposti dalla metrica in poesia: stimolano soluzioni nuove, sfide espressive, invenzioni.
Certo, esiste il rischio di omologazione: se tutti parlano nello stesso modo per piacere all’algoritmo, si rischia una perdita di varietà. Ma è un rischio che si può contrastare proprio prendendo coscienza del meccanismo. L’algolingua non è una trappola: è uno strumento, e come ogni strumento, può essere usato anche in modo critico e consapevole.
Slengo e l’osservatorio dell’algolingua
In quanto dizionario del gergo contemporaneo, Slengo si trova in una posizione privilegiata per osservare l’algolingua in azione. Molti dei neologismi che registriamo nascono proprio da questo terreno fertile: incrocio tra creatività, strategia comunicativa, appartenenza e algoritmi.
Monitorare questi fenomeni significa anche dare visibilità a ciò che accade davvero nella lingua, non a ciò che dovrebbe accadere secondo la norma. L’italiano è vivo, e oggi respira anche al ritmo del feed. Se vogliamo capire dove sta andando, dobbiamo ascoltarlo mentre parla al telefono, scrive nei DM, monta un TikTok. L’algolingua fa parte della lingua di oggi. E la lingua di oggi merita di essere raccontata.
Se ti interessa questo argomento, consigliamo la lettura (in inglese) del libro Algospeak: How Social Media is Transforming the Future of Language di Adam Aleksic, usato anche come ispirazione per la scrittura dell’articolo.
Nell’articolo si è parlato di etichette identitarie. Se vuoi approfondire, ti consigliamo il nostro articolo sui neologismi in -core legati alla moda e al design. Lo trovi qui sotto!